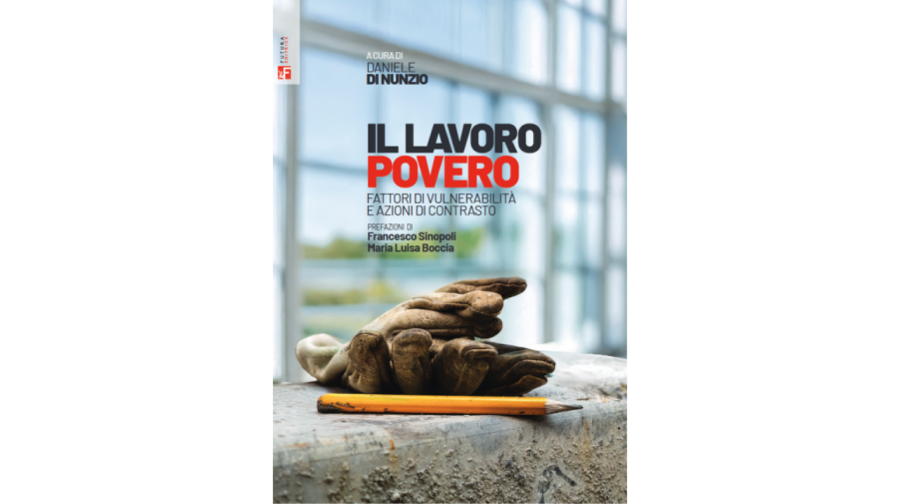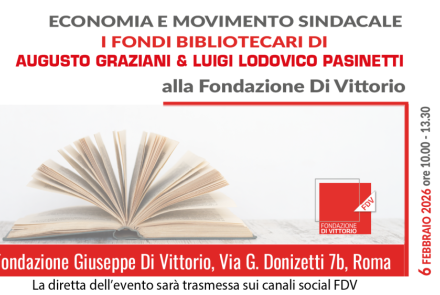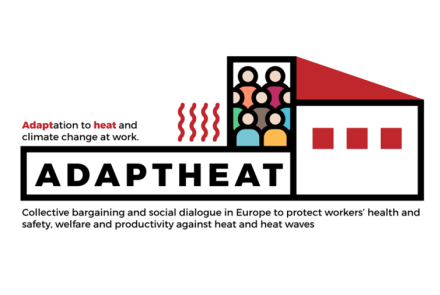Il lavoro povero, fattori di vulnerabilità e azioni di contrasto: intervista a Daniele di Nunzio, curatore del volume
Segnaliamo l'intervista di Marco Omizzolo, sociologo, docente e ricercatore dell’Eurispes, a Daniele Di Nunzio, responsabile dell'area ricerca della Fondazione Di Vittorio. L'intervista è sul volume, edito da Futura Edizioni, dal titolo "Il lavoro povero, fattori di vulnerabilità e azioni di contrasto" curato dallo stesso Di Nunzio. Il volume presenta un’analisi del lavoro povero come fenomeno multifattoriale e delle pratiche necessarie per contrastarlo. La ricerca ha analizzato il ruolo della contrattazione (nazionale, aziendale, territoriale) e le azioni di carattere sociale e istituzionale. l progetto è stato coordinato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e condotto in collaborazione con il Centro di Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato con un gruppo di ricerca interdisciplinare.
Il volume è liberamente scaricabile QUI
Ecco il testo dell'intervista, inizialmente pubblicata QUI, sul sito leurispes.it
Lei è curatore del libro Lavoro povero (2025), pubblicato da Futura editrice. La prima fondamentale domanda è: che cosa è oggi il lavoro povero in Italia secondo la vostra ricerca?
Il lavoro povero è, prima di tutto, un problema vissuto dalle persone nella loro vita quotidiana. È l’esperienza drammatica di chi, pur lavorando, non riesce a soddisfare le esigenze fondamentali per sé e per la propria famiglia. Queste persone hanno bisogno di un supporto mirato da parte delle istituzioni, di sostegni economici, di una prospettiva di fuoriuscita dalla povertà. Al tempo stesso, il lavoro povero, anche se investe la vita di singole persone, non può essere affrontato come un problema individuale, poiché interroga il modello di sviluppo nella sua totalità. Il lavoro povero è un fenomeno complesso e in questa ricerca abbiamo cercato di indagarlo considerando un ampio spettro di fattori: a) la condizione occupazionale e famigliare dell’individuo; b) il contesto aziendale e produttivo; c) il contesto territoriale. Questi ambiti di vita e di lavoro sono degli spazi di intervento, tra loro in relazione, nei quali gli attori sociali e politici operano, o dovrebbero operare, per favorire l’aumento dei salari e, più in generale, il superamento degli elementi di precarietà del lavoro.
Gli ambiti lavorativi trattati in questo libro sono diversi. Si passa dal settore agricolo, analizzando in particolare il lavoro dei migranti in agricoltura in provincia di Latina, al settore delle costruzioni in Veneto, ai consumi turistici a Matera, sino al lavoro nei servizi di assistenza domiciliare e a quello da remoto nelle aree interne delle Madonie. Quali sono i principali risultati di queste specifiche ricerche?
L’analisi di questi studi di caso rende evidente che il lavoro povero è un problema sociale e politico. Il ruolo delle istituzioni, delle parti sociali, datoriali e sindacali, delle associazioni, è fondamentale per fronteggiarlo e loro assenza inasprisce le condizioni di rischio e di vulnerabilità. Nel settore delle costruzioni, la capacità di governare la catena di appalti e di costruire dei sistemi di relazioni industriali efficaci (come gli enti bilaterali e le indennità di disoccupazione) è determinante per fronteggiare lo sfruttamento del lavoro e la precarietà data dalla natura temporanea dei cantieri. Nell’agricoltura, il contrasto alle tante forme di illegalità, a partire dal caporalato, e le politiche di inclusione dei migranti, sono fondamentali per contrastare il lavoro povero, facendo pressioni da un lato, sulle istituzioni, dall’altro sui soggetti centrali nelle filiere che mirano all’abbassamento del costo della manodopera. Nel lavoro di cura a domicilio, la scelta di esternalizzare e privatizzare un servizio sanitario fondamentale ha esposto le lavoratrici e i lavoratori a una competizione al ribasso, in termini di salari e di qualità del lavoro. La cura a domicilio è un diritto di chi non è auto-sufficiente e un’attività che non può essere lasciata alle logiche del mercato. A Matera, le scarse politiche istituzionali di valorizzazione del territorio hanno comportato lo sviluppo di un turismo fondato sulla micro-impresa, spesso individuale, perdendo l’occasione di mettere a frutto i benefici conseguenti alla nomina di capitale europea della cultura. Nelle aree interne, come nel caso delle Madonie, la carenza di servizi pubblici, come i trasporti, può aumentare i costi della vita e, dunque, diminuire il potere di acquisto.
Questi studi, dunque, ci restituiscono tanti percorsi di lavoro povero e i tratti comuni, che si possono osservare, sono la carenza di un supporto istituzionale, la scarsa collaborazione tra gli attori politici e sociali, la frammentazione ed esclusione dai sistemi di rappresentanza e tutela delle lavoratrici e lavoratori più fragili. D’altra parte, le pratiche di contrasto nascono anche in questi settori e si fondano su logiche opposte che mettono al centro la creazione di reti di supporto e strategie di sviluppo alternative e condivise.
Quasi in conclusione del libro, con un suo saggio lei introduce il concetto di lavoro povero come vulnerabilità complessa. Che cosa intende esattamente?
Il lavoro povero si caratterizza per una pluralità di concettualizzazioni, di dimensioni analitiche, di esperienze con cui si manifesta nella vita individuale e sociale, e dunque per una “estrema polisemia” propria della condizione di precarietà, per cui i bassi salari si associano a numerose altre vulnerabilità, come la difficoltà di contrattare le condizioni di lavoro, l’assenza di protezioni sociali, poche opportunità di formazione, processi di sfruttamento e autosfruttamento, insicurezza e paura per il proprio futuro. La povertà associata al lavoro si sperimenta in molteplici modi da parte degli individui, quali ad esempio non solo una povertà economica ma, anche, una povertà sociale, provocata da una carenza di supporti famigliari e istituzionali, dal rischio di dequalificazione, disagi abitativi, assenza di tutele legali, esclusione dalle reti aggregative, dalla socializzazione, e così via. Senza dimenticare le ripercussioni, ad esempio, per chi cresce in famiglie di lavoratrici e lavoratori poveri e, dunque, le conseguenze per le generazioni future.
La povertà è causata da numerosi fattori e, al tempo stesso, si traduce in molteplici mancanze, per cui le azioni di contrasto dovrebbero essere condotte con un approccio altrettanto complesso, partendo dai bisogni espressi dalle lavoratrici/tori in relazione alla loro condizione lavorativa e a quella sociale. La ricerca che abbiamo fatto, pubblicata nel volume “Il lavoro povero. Fattori di vulnerabilità e azioni di contrasto” è, difatti, un lavoro collettivo condotto con un approccio transdisciplinare, con analisi di carattere storico, giuridico, economico, sociale, nel tentativo di restituire la complessità di queste sfide.
Quali caratteristiche assume il lavoro povero, sociologicamente parlando, nel momento in cui in questa condizione si trova una donna o un migrante?
Più si è fragili nel mondo del lavoro e più si è costretti ad accettare condizioni difficili, anche sul lato economico. Le donne vivono spesso il problema di un part-time involontario, determinato anche dai compiti di cura famigliare che pesano maggiormente sulle loro spalle, e da un gender-gap salariale che comporta stipendi più bassi anche a parità di ore di lavoro e di mansione. Per i migranti le difficoltà investono ogni ambito e la loro stessa possibilità di costruire in Italia un percorso di vita è esposta al ricatto occupazionale ed è messa nelle mani del mercato, dove i datori più spietati ne approfittano. In entrambi i casi, per le donne e per i migranti, il lavoro rischia di essere sottoposto a un ricatto. La paga, il rapporto tra impegno e retribuzione, è condizionata da rapporti di forza enormemente sbilanciati.
Il rapporto tra lavoro povero e sindacato che cosa sollecita? Quali proposte lei sentirebbe di avanzare al mondo sindacale complessivamente inteso per fronteggiare e sconfiggere il lavoro povero in Italia e con esso anche lo sfruttamento?
Il contrasto al lavoro povero comporta per il sindacato la necessità di rafforzare le pratiche di intervento nei confronti dei soggetti più vulnerabili ed esclusi dalle reti di rappresentanza. Per il sindacato, questo significa costruire delle logiche di azione volte a intercettare, coinvolgere, tutelare i soggetti più esclusi, quelli che vivono e operano ai margini delle filiere produttive e dei sistemi di diritti consolidati, come ad esempio prova a fare la Flai-Cgil con il sindacalismo di strada nell’agricoltura. Questo comporta l’esigenza di costruire un’azione sindacale capace di mettere in rete i diversi attori che operano per l’affermazione dei diritti, di tipo istituzionale e associativo. Al tempo stesso, il sindacato deve ricostruire i percorsi di rappresentanza consentendo ai soggetti più vulnerabili non solo di essere inclusi nelle reti di azione collettiva ma di esserne protagonisti, governando l’evoluzione stessa dell’organizzazione sindacale. Ci sono poi lotte di ordine generale, da affermare, come quella per il salario minimo e il reddito di cittadinanza, che appaiono come diritti fondamentali per porre un limite netto al potere dei mercati, stabilendo il principio universale di avere un giusto salario quando si lavora, e una giusta redistribuzione delle ricchezze a prescindere dalla condizione occupazionale.
Lei ha scritto un saggio riguardante le azioni di contrasto al lavoro povero. Quali sono le proposte che ritiene possibile avanzare al governo del Paese per sconfiggere il lavoro povero?
I fattori che determinano il lavoro povero sono così numerosi, articolati e dinamici nel loro intreccio che da un lato è necessario individuare delle tutele di ordine generale, universale, superiori ai contesti specifici (considerando appunto il salario minimo, il reddito di cittadinanza non condizionato al lavoro, i diritti di formazione continua, e così via), per difendere la persona in qualsiasi condizione si possa trovare. D’altra parte, è necessario rafforzare la capacità di costruire degli interventi specializzati, mirati in relazione alle caratteristiche individuali, famigliari, aziendali, settoriali, territoriali. Bisogna dunque tenere insieme il livello macro dell’azione con quello micro. Purtroppo, formule semplici non esistono e quando qualcuno propone una soluzione facile è perché non vuole risolvere il problema. Il contrasto al lavoro povero si basa sulla possibilità dei lavoratori/trici di resistere al ricatto occupazionale, di organizzarsi e proporre delle soluzioni, di favorire la collaborazione tra tutti gli attori, considerando le parti sociali, le associazioni, le istituzioni. Il contrasto al lavoro povero nasce da una elaborazione collettiva sui problemi e dalla capacità di costruire insieme le soluzioni. Dunque, affermazione della democrazia, affermazione del modello di sviluppo, affermazione della dignità del lavoro, sono degli elementi tra loro in relazione.
*Marco Omizzolo, sociologo, docente e ricercatore dell’Eurispes.